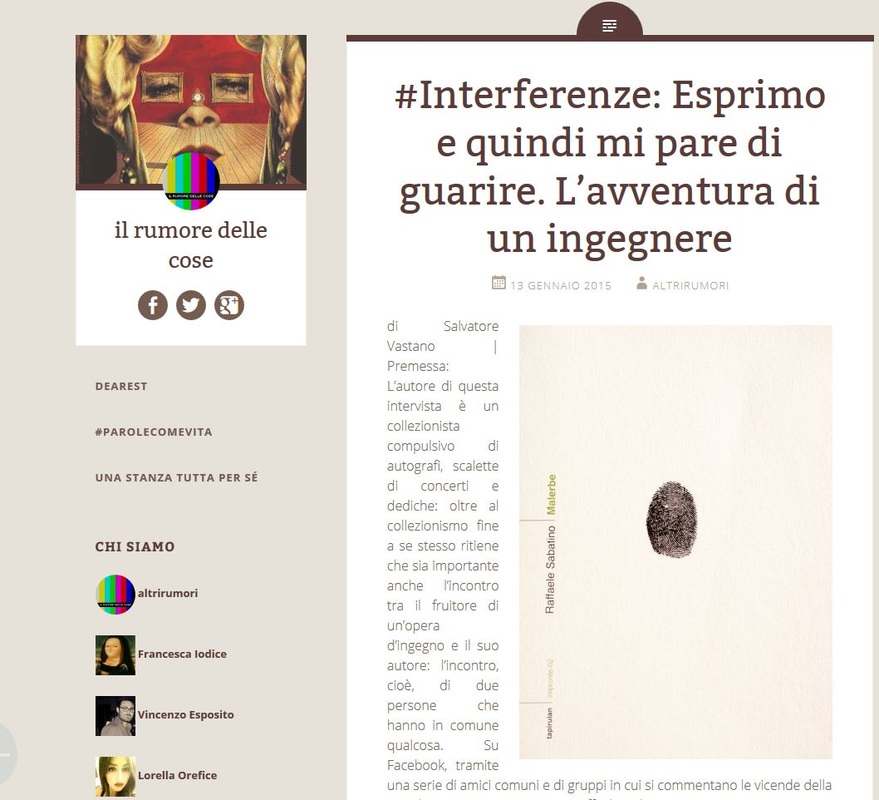|
Condividi:
|
|
Intervista del 13.01.2015, a cura di Salvatore Vastano per il blog Il rumore delle cose. Il blog è qui:
https://ilrumoredellecose.wordpress.com/
https://ilrumoredellecose.wordpress.com/
#Interferenze: Esprimo e quindi mi pare di guarire. L’avventura di un ingegnere
di Salvatore Vastano
Premessa: L’autore di questa intervista è un collezionista compulsivo di autografi, scalette di concerti e dediche: oltre al collezionismo fine a se stesso ritiene che sia importante anche l’incontro tra il fruitore di un’opera d’ingegno e il suo autore: l’incontro, cioè, di due persone che hanno in comune qualcosa. Su Facebook, tramite una serie di amici comuni e di gruppi in cui si commentano le vicende della vita di provincia, mi aggiunse Raffaele Sabatino, un ingegnere casertano che vive e lavora in Svizzera: sul suo profilo Raffaele però non pubblica né stati, né foto, né inviti a giochi, ma solamente le sue poesie: di tanto in tanto, a cadenza non regolare mi uscivano sulla home questi testi poetici (anche abbastanza lunghi, in vero) che ho cominciato a leggere. Quello che mi colpiva del modo che Sabatino ha di esprimersi è che, a differenza della maggior parte delle poesie che si leggono di solito, scritte da poeti contemporanei laureati e non, esiste ancora una dimensione del linguaggio che comunica qualcosa, che non è scarnificato come ormai siamo abituati a leggere da Montale in poi. Oltre quindi alla volontà di comunicare qualcosa, nelle poesie di Sabatino non c’è mai una soluzione precostituita, un fine che si può intendere dalle prime battute o dal titolo: anzi spesso ho avvertito, leggendo, che il discorso parte da alcune premesse per poi svilupparsi, quasi che la poesia stessa sia parte di un pensiero che parte, si evolve e arriva (ma non è necessario) a delle conclusioni: le premesse sono poi offerte non da temi generici come l’amore, il senso della vita, la morte (temi che pure ci sono, beninteso) affrontati dall’alto o con una espressività eccessiva, ma da una serie di fatti concreti che portano con sé una serie di riflessioni concrete. Mentre noi letterati ci perdiamo nel cercare di definire il dover essere che pensiamo deve essere, cercando di salire invano sull’aerostato di Platone, l’ingegnere ci ricorda che, come diceva David Foster Wallace, siamo tanti pesciolini in un acquario e dobbiamo ripeterci che “questa è acqua, questa è acqua”.
È possibile trovare Malerbe, la sua raccolta di poesie, su ibs http://www.ibs.it/e sul sito di Tapirulan www.tapirulan.it
Ciao Raffaele, come va in Svizzera?
In Svizzera “va”. Occorre forse precisare che io vivo nella Svizzera “tedesca”, perché il Ticino (la cosiddetta Svizzera “italiana) e quella “francese” sono molto diverse. Qui tutto funziona, la burocrazia è quasi nulla, il settore pubblico non è sinonimo di privilegio e intoccabilità e il lavoro (che c’è, ma sempre meno per persone poco qualificate) è la preoccupazione numero uno della gente (ottenerlo, o mantenerlo). Culturalmente, si tratta di una babele di persone da tutto il mondo (il 25% della popolazione è composta da immigrati) che rende il tutto affascinante e, allo stesso tempo, complesso.
Io ci vivo sotto la “maledizione” di Pasolini, il quale una volta scrisse che l’emigrazione era solo un’illusione, un vendersi all’idea istruttiva dell’efficienza. Ci sto, anche, tenendo a mente quello che una volta l’attore Mario Adorf disse a un giornalista il quale gli chiedeva cosa fosse per lui Roma, dove viveva da anni: “un posto dove vivere”. E ricordandomi che, se ci sono venuto, un motivo ci sarà stato.
Tu scrivi poesie: raccontaci com’è nata questa tua attività e come la vivi proprio praticamente: quali strumenti usi per scrivere e in quali momenti della tua giornata di ingegnere in Svizzera scrivi.
Lo scrivere è nato come esigenza quasi “terapeutica” di dire certe cose e di dirle in un certo modo, facilitata da una forte predisposizione alla cosiddetta “creatività verbale” e al gusto di dire le cose in maniera non banale, ma profonda e formalmente elegante. Con qualche altro elemento che facilita la tecnica dello scrivere, come per esempio la capacità innata di contare le lettere che compongono le frasi. Funziona così: uno mi dice una frase e io, nel giro di 2-3 secondi, gli dico “ottantasette”, o “cinquantotto”, o “novantuno”. Quello allora si scrive (o rilegge) quello che ha detto e verifica che il numero di lettere corrisponde. Poi dice incredulo “ma comm’ fa?”. Come dicevano a Gigino il poeta dei film di Bellavista, quando recitava i “pensieri poetici” nel condominio. Mi ricordo che iniziai da piccolo, quando per evadere dalla realtà guardavo, fuori dal finestrino di una cinquecento, i cartelli o le insegne dei negozi, e cominciai a contare le lettere delle scritte. Una specie di capacità circense insomma che in poesia, dove il ritmo è (per me) fondamentale, è molto utile. E che dà, devo dire, molta puerile soddisfazione. Poi ho pure “scoperto” o inventato una specie di teorema sulla lunghezza delle parole nella lingua italiana, che porta all’esistenza di numeri “magici”, ma questa è un’altra storia.
Venendo alla seconda parte della domanda: in me, per scrivere ogni momento è buono. Il treno per andare e venire dall’ufficio, fasi “morte” sul lavoro, bagno, spesso pure mentre corro (faccio jogging e mi vengono a volte delle frasi che successivamente trascrivo), ancora più spesso la mattina presto o la sera tardi. Prima usavo il classico taccuino tipo Hemingway, o tovaglioli, carta di vario genere all’occorrenza, mentre da qualche anno trovo molto comodo il solito smartphone: ce l’ho comunque sempre addosso, inoltre sincronizzo cose, appunti o prodotto finito usando anche la mail e messaggerie varie, per cui posso davvero iniziare e finire dovunque, o iniziare per strada e finire al computer di casa. Cose del genere.
E che cos’è per te la poesia? Inizi a scrivere sapendo già come finirai oppure è un lavoro che gestisci in più tempi?
Il motore, per me, è l’aspetto di terapia a cui accennavo prima, una sorta di liberazione euforica dai miei tarli che provo ogni volta che penso “bella questa”, una volta finito. L’eccitazione del “mentre”, anche. Esprimo e quindi mi pare di guarire, anche se solo per poco. Credo che la scrittura creativa abbia un forte potere, quasi taumaturgico, in questo senso. Un mio sogno è quello di fare uno studio psicologico-letterario su questo, ma prima dovrei trovare un terapeuta sensibile al tema. Quindi terapia autoindotta. E bellezza. E anche il riscontro di chi mi legge.
Spesso non so come “finirò”. La domanda non è banale, perché la chiosa di una poesia è fondamentale, a mia opinione, per cui quando capita che mi viene una buona chiusura prima di tutto è bellissimo, perché quella si tira dietro tutto il resto ed è, in generale, la parte più difficile. In generale funziona che mi viene un’idea, cioè un tema, o un concetto. Può essere un oggetto, o una situazione, o una riflessione (in questo la poesia ha molto a che fare con la filosofia, o la psicologia, che infatti fino a centocinquanta anni fa non esisteva e si confondeva con la prima), o un verso che si manifesta già “finito”, e come dicevo può accadere di notte, di mattina presto, in treno, al lavoro. La precondizione è, comunque, sempre una buona dose di inquietudine, di agitazione interiore. A pancia piena (emotivamente) non si crea nulla. O almeno io non ne sono capace.
Parto quindi da questo “nucleo”, come i granelli di silicio intorno a cui si fa (o si faceva) crescere tutto il resto del materiale elettronico. Una specie di embrione che però, per svilupparsi, ha bisogno di essere scritto, cioè “visto” (raramente mi succede, come in certi romanzi, che l’opera “si manifesti” già tutta compiuta). Una volta scritti questi elementi embrionali, il lavoro è in genere rapido e, se come dicevo di essi fa parte una chiosa potente, lo è ancora di più. Minuti, magari un paio di ore. La tecnica non è un problema, e scelgo soluzioni diverse a seconda del tema o dell’ispirazione. In genere endecasillabi opportunamente (me lo disse una volta un critico) alterati, ma anche Haiku usati però non a sé stanti, quanto piuttosto come mattoni costitutivi. Questo ultimo approccio si presta bene a versi laconici, sintetici, sferzanti come mi piace fare per esempio per temi “sociali” o “politici”.
A volte però il lavoro non “quaglia”, e allora metto da parte. Poi riprendo o rivisito, magari mesi dopo. Per le cose non “quagliate” uso sempre lo stesso carattere come prefisso per il titolo, così le scorro facilmente con il computer o con lo smartphone quando ne ho voglia. A volte, dopo mesi, uso “embrioni” che erano nati per tutt’altro scopo o sotto una suggestione completamente diversa. Questa seconda strada è, però, in genere più accidentata e vale quello che la presunta veggente dice al povero derubato di Ladri di biciclette a proposito della bici: “O la trovi subito, o non la trovi più”. Lo stesso vale per la poesia, e per lo scrivere in genere.
Ma comunque, spesso, la poesia trova la strada da sola, come se fosse insita in me ma vivesse di vita autonoma. In questo è veramente un mistero. Poco riproducibile. Ne sento la caducità ogni volta, e ogni volta mi chiedo chissà se ci sarà ancora, domani.
Che rapporto hai con le tue poesie? Le rivedi e le riscrivi oppure, una volta definite, le lasci così?
Le poesie (ma anche delle cose in prosa, che anche scrivo e che sono quelle cose che tu hai definito come lunghe) sono degli agglomerati, miei, che per coloro i quali li leggono diventano i “loro” agglomerati e assumono spesso dei significati completamente estranei a me che li ho ideati. In questo senso ho un rapporto con loro di “liberazione”, cioè una volta concluse tendo a non manipolarle più. Tendo, perché poi è anche vero che, come disse qualcuno, “le poesie non sono mai finite”, e allora rimaneggio. Ma si tratta in genere di aggiustamenti di poco conto (spesso il titolo, o un verso), almeno per le cose che ritengo già di buon livello, perché quelle non “all’altezza” o incomplete vanno, come dicevo, a far parte del serbatoio col prefisso a cui attingere in tempi successivi.
Borges dice che nessuno può essere scrittore senza essere lettore: tu che lettore sei? Puoi dire 5 titoli di libri che porteresti con te su un’isola deserta?
Io sono un lettore abbastanza avido, seppure a volte discontinuo. Sono una specie di spugna “stilistica”, nel leggere, nel senso che compenso il non-dono della citazione (adoro quelli che snocciolano citazioni, ovviamente se lo fanno in modo appropriato) con una sorta di meta-comprensione dello scritto che magari viene fuori in quello che faccio io anche mesi o anni dopo la lettura.
I miei cinque libri (limitandomi alla prosa) sono:
Sostiene Pereira, di A. Tabucchi
Oggetto quasi, di J. Saramago
Ti con zero, di I. Calvino
Post office, di C. Bukowski
Il sistema periodico, di P. Levi
Nelle poesie di solito si parla di sé (qualcuno ha detto che “ci si mette a nudo”): tu come gestisci il pudore?
Non lo gestisco, semplicemente. Sono fin troppo “spudorato”, nello scrivere. Non sconcio ovviamente (la poesia non può permettersi di essere volgare, se non in ben definiti e dichiarati contesti), ma la autenticità è necessaria, almeno nella mia interpretazione di questa “cosa”. Ci possono essere, ovviamente, traslazioni spazio-temporali di situazioni o sentimenti , ma in genere mi metto molto a nudo e nelle mie poesie ”si tratta” quasi sempre di me o di fatti vissuti da me, o in cui mi sono proiettato.
Ci sono persone che vorresti non leggessero mai le tue poesie?
Starei per dire gli imbecilli, ma quelli in genere non vanno oltre un paio di versi e poi arrivano subito a conclusioni definitive. Avere idee definitive è molto da imbecilli. Oppure dicono “non l’ho capita, ma bravo!”.
Quindi, a patto che io accetti di sentire un paio di commenti “definitivi”, in fondo le possono leggere tutti. Poi è difficile sapere in anticipo, sulla fiducia, se uno è imbecille o no e la poesia, comunque, non ne cambierà la predisposizione.
di Salvatore Vastano
Premessa: L’autore di questa intervista è un collezionista compulsivo di autografi, scalette di concerti e dediche: oltre al collezionismo fine a se stesso ritiene che sia importante anche l’incontro tra il fruitore di un’opera d’ingegno e il suo autore: l’incontro, cioè, di due persone che hanno in comune qualcosa. Su Facebook, tramite una serie di amici comuni e di gruppi in cui si commentano le vicende della vita di provincia, mi aggiunse Raffaele Sabatino, un ingegnere casertano che vive e lavora in Svizzera: sul suo profilo Raffaele però non pubblica né stati, né foto, né inviti a giochi, ma solamente le sue poesie: di tanto in tanto, a cadenza non regolare mi uscivano sulla home questi testi poetici (anche abbastanza lunghi, in vero) che ho cominciato a leggere. Quello che mi colpiva del modo che Sabatino ha di esprimersi è che, a differenza della maggior parte delle poesie che si leggono di solito, scritte da poeti contemporanei laureati e non, esiste ancora una dimensione del linguaggio che comunica qualcosa, che non è scarnificato come ormai siamo abituati a leggere da Montale in poi. Oltre quindi alla volontà di comunicare qualcosa, nelle poesie di Sabatino non c’è mai una soluzione precostituita, un fine che si può intendere dalle prime battute o dal titolo: anzi spesso ho avvertito, leggendo, che il discorso parte da alcune premesse per poi svilupparsi, quasi che la poesia stessa sia parte di un pensiero che parte, si evolve e arriva (ma non è necessario) a delle conclusioni: le premesse sono poi offerte non da temi generici come l’amore, il senso della vita, la morte (temi che pure ci sono, beninteso) affrontati dall’alto o con una espressività eccessiva, ma da una serie di fatti concreti che portano con sé una serie di riflessioni concrete. Mentre noi letterati ci perdiamo nel cercare di definire il dover essere che pensiamo deve essere, cercando di salire invano sull’aerostato di Platone, l’ingegnere ci ricorda che, come diceva David Foster Wallace, siamo tanti pesciolini in un acquario e dobbiamo ripeterci che “questa è acqua, questa è acqua”.
È possibile trovare Malerbe, la sua raccolta di poesie, su ibs http://www.ibs.it/e sul sito di Tapirulan www.tapirulan.it
Ciao Raffaele, come va in Svizzera?
In Svizzera “va”. Occorre forse precisare che io vivo nella Svizzera “tedesca”, perché il Ticino (la cosiddetta Svizzera “italiana) e quella “francese” sono molto diverse. Qui tutto funziona, la burocrazia è quasi nulla, il settore pubblico non è sinonimo di privilegio e intoccabilità e il lavoro (che c’è, ma sempre meno per persone poco qualificate) è la preoccupazione numero uno della gente (ottenerlo, o mantenerlo). Culturalmente, si tratta di una babele di persone da tutto il mondo (il 25% della popolazione è composta da immigrati) che rende il tutto affascinante e, allo stesso tempo, complesso.
Io ci vivo sotto la “maledizione” di Pasolini, il quale una volta scrisse che l’emigrazione era solo un’illusione, un vendersi all’idea istruttiva dell’efficienza. Ci sto, anche, tenendo a mente quello che una volta l’attore Mario Adorf disse a un giornalista il quale gli chiedeva cosa fosse per lui Roma, dove viveva da anni: “un posto dove vivere”. E ricordandomi che, se ci sono venuto, un motivo ci sarà stato.
Tu scrivi poesie: raccontaci com’è nata questa tua attività e come la vivi proprio praticamente: quali strumenti usi per scrivere e in quali momenti della tua giornata di ingegnere in Svizzera scrivi.
Lo scrivere è nato come esigenza quasi “terapeutica” di dire certe cose e di dirle in un certo modo, facilitata da una forte predisposizione alla cosiddetta “creatività verbale” e al gusto di dire le cose in maniera non banale, ma profonda e formalmente elegante. Con qualche altro elemento che facilita la tecnica dello scrivere, come per esempio la capacità innata di contare le lettere che compongono le frasi. Funziona così: uno mi dice una frase e io, nel giro di 2-3 secondi, gli dico “ottantasette”, o “cinquantotto”, o “novantuno”. Quello allora si scrive (o rilegge) quello che ha detto e verifica che il numero di lettere corrisponde. Poi dice incredulo “ma comm’ fa?”. Come dicevano a Gigino il poeta dei film di Bellavista, quando recitava i “pensieri poetici” nel condominio. Mi ricordo che iniziai da piccolo, quando per evadere dalla realtà guardavo, fuori dal finestrino di una cinquecento, i cartelli o le insegne dei negozi, e cominciai a contare le lettere delle scritte. Una specie di capacità circense insomma che in poesia, dove il ritmo è (per me) fondamentale, è molto utile. E che dà, devo dire, molta puerile soddisfazione. Poi ho pure “scoperto” o inventato una specie di teorema sulla lunghezza delle parole nella lingua italiana, che porta all’esistenza di numeri “magici”, ma questa è un’altra storia.
Venendo alla seconda parte della domanda: in me, per scrivere ogni momento è buono. Il treno per andare e venire dall’ufficio, fasi “morte” sul lavoro, bagno, spesso pure mentre corro (faccio jogging e mi vengono a volte delle frasi che successivamente trascrivo), ancora più spesso la mattina presto o la sera tardi. Prima usavo il classico taccuino tipo Hemingway, o tovaglioli, carta di vario genere all’occorrenza, mentre da qualche anno trovo molto comodo il solito smartphone: ce l’ho comunque sempre addosso, inoltre sincronizzo cose, appunti o prodotto finito usando anche la mail e messaggerie varie, per cui posso davvero iniziare e finire dovunque, o iniziare per strada e finire al computer di casa. Cose del genere.
E che cos’è per te la poesia? Inizi a scrivere sapendo già come finirai oppure è un lavoro che gestisci in più tempi?
Il motore, per me, è l’aspetto di terapia a cui accennavo prima, una sorta di liberazione euforica dai miei tarli che provo ogni volta che penso “bella questa”, una volta finito. L’eccitazione del “mentre”, anche. Esprimo e quindi mi pare di guarire, anche se solo per poco. Credo che la scrittura creativa abbia un forte potere, quasi taumaturgico, in questo senso. Un mio sogno è quello di fare uno studio psicologico-letterario su questo, ma prima dovrei trovare un terapeuta sensibile al tema. Quindi terapia autoindotta. E bellezza. E anche il riscontro di chi mi legge.
Spesso non so come “finirò”. La domanda non è banale, perché la chiosa di una poesia è fondamentale, a mia opinione, per cui quando capita che mi viene una buona chiusura prima di tutto è bellissimo, perché quella si tira dietro tutto il resto ed è, in generale, la parte più difficile. In generale funziona che mi viene un’idea, cioè un tema, o un concetto. Può essere un oggetto, o una situazione, o una riflessione (in questo la poesia ha molto a che fare con la filosofia, o la psicologia, che infatti fino a centocinquanta anni fa non esisteva e si confondeva con la prima), o un verso che si manifesta già “finito”, e come dicevo può accadere di notte, di mattina presto, in treno, al lavoro. La precondizione è, comunque, sempre una buona dose di inquietudine, di agitazione interiore. A pancia piena (emotivamente) non si crea nulla. O almeno io non ne sono capace.
Parto quindi da questo “nucleo”, come i granelli di silicio intorno a cui si fa (o si faceva) crescere tutto il resto del materiale elettronico. Una specie di embrione che però, per svilupparsi, ha bisogno di essere scritto, cioè “visto” (raramente mi succede, come in certi romanzi, che l’opera “si manifesti” già tutta compiuta). Una volta scritti questi elementi embrionali, il lavoro è in genere rapido e, se come dicevo di essi fa parte una chiosa potente, lo è ancora di più. Minuti, magari un paio di ore. La tecnica non è un problema, e scelgo soluzioni diverse a seconda del tema o dell’ispirazione. In genere endecasillabi opportunamente (me lo disse una volta un critico) alterati, ma anche Haiku usati però non a sé stanti, quanto piuttosto come mattoni costitutivi. Questo ultimo approccio si presta bene a versi laconici, sintetici, sferzanti come mi piace fare per esempio per temi “sociali” o “politici”.
A volte però il lavoro non “quaglia”, e allora metto da parte. Poi riprendo o rivisito, magari mesi dopo. Per le cose non “quagliate” uso sempre lo stesso carattere come prefisso per il titolo, così le scorro facilmente con il computer o con lo smartphone quando ne ho voglia. A volte, dopo mesi, uso “embrioni” che erano nati per tutt’altro scopo o sotto una suggestione completamente diversa. Questa seconda strada è, però, in genere più accidentata e vale quello che la presunta veggente dice al povero derubato di Ladri di biciclette a proposito della bici: “O la trovi subito, o non la trovi più”. Lo stesso vale per la poesia, e per lo scrivere in genere.
Ma comunque, spesso, la poesia trova la strada da sola, come se fosse insita in me ma vivesse di vita autonoma. In questo è veramente un mistero. Poco riproducibile. Ne sento la caducità ogni volta, e ogni volta mi chiedo chissà se ci sarà ancora, domani.
Che rapporto hai con le tue poesie? Le rivedi e le riscrivi oppure, una volta definite, le lasci così?
Le poesie (ma anche delle cose in prosa, che anche scrivo e che sono quelle cose che tu hai definito come lunghe) sono degli agglomerati, miei, che per coloro i quali li leggono diventano i “loro” agglomerati e assumono spesso dei significati completamente estranei a me che li ho ideati. In questo senso ho un rapporto con loro di “liberazione”, cioè una volta concluse tendo a non manipolarle più. Tendo, perché poi è anche vero che, come disse qualcuno, “le poesie non sono mai finite”, e allora rimaneggio. Ma si tratta in genere di aggiustamenti di poco conto (spesso il titolo, o un verso), almeno per le cose che ritengo già di buon livello, perché quelle non “all’altezza” o incomplete vanno, come dicevo, a far parte del serbatoio col prefisso a cui attingere in tempi successivi.
Borges dice che nessuno può essere scrittore senza essere lettore: tu che lettore sei? Puoi dire 5 titoli di libri che porteresti con te su un’isola deserta?
Io sono un lettore abbastanza avido, seppure a volte discontinuo. Sono una specie di spugna “stilistica”, nel leggere, nel senso che compenso il non-dono della citazione (adoro quelli che snocciolano citazioni, ovviamente se lo fanno in modo appropriato) con una sorta di meta-comprensione dello scritto che magari viene fuori in quello che faccio io anche mesi o anni dopo la lettura.
I miei cinque libri (limitandomi alla prosa) sono:
Sostiene Pereira, di A. Tabucchi
Oggetto quasi, di J. Saramago
Ti con zero, di I. Calvino
Post office, di C. Bukowski
Il sistema periodico, di P. Levi
Nelle poesie di solito si parla di sé (qualcuno ha detto che “ci si mette a nudo”): tu come gestisci il pudore?
Non lo gestisco, semplicemente. Sono fin troppo “spudorato”, nello scrivere. Non sconcio ovviamente (la poesia non può permettersi di essere volgare, se non in ben definiti e dichiarati contesti), ma la autenticità è necessaria, almeno nella mia interpretazione di questa “cosa”. Ci possono essere, ovviamente, traslazioni spazio-temporali di situazioni o sentimenti , ma in genere mi metto molto a nudo e nelle mie poesie ”si tratta” quasi sempre di me o di fatti vissuti da me, o in cui mi sono proiettato.
Ci sono persone che vorresti non leggessero mai le tue poesie?
Starei per dire gli imbecilli, ma quelli in genere non vanno oltre un paio di versi e poi arrivano subito a conclusioni definitive. Avere idee definitive è molto da imbecilli. Oppure dicono “non l’ho capita, ma bravo!”.
Quindi, a patto che io accetti di sentire un paio di commenti “definitivi”, in fondo le possono leggere tutti. Poi è difficile sapere in anticipo, sulla fiducia, se uno è imbecille o no e la poesia, comunque, non ne cambierà la predisposizione.

Oltre la poesia: cosa ti piace fare nella vita?
Mi piace il cinema, poi mi piace correre. Mi piace viaggiare. Mi piace disegnare (ma lo faccio solo occasionalmente) e fotografare. Mi piacerebbe suonare, ma non ho mai imparato e forse lo farò. Mi piace ascoltare le storie degli altri (in un’altra vita forse farò lo psicologo). Mi piace osservare la crescita del mio bambino, la formazione delle sue idee, delle sue paure, la sua visione del mondo. Mi piacerebbe anche parlare molto e “scambiare” idee con altri esseri umani, cosa però per me al momento obbiettivamente abbastanza limitata. Quindi lo faccio indirettamente, scrivendo.
Sei un tifoso della JuveCaserta: cosa pensi del campionato?
Mentre sto scrivendo siamo alla tredicesima sconfitta consecutiva dall’inizio del campionato. Una cosa più unica che rara e che mi colpisce particolarmente, non solo da tifoso, ma perché mi pare che i risultati siano inversamente proporzionali agli sforzi della società (rinnovata attenzione al settore giovanile, restauro di vari luoghi cittadini di pallacanestro, collaborazione con la struttura dei salesiani e tante altre iniziative). Credo siano stati fatti degli errori di costruzione del roster. Gaines non valeva Roberts ma si voleva una guardia tiratrice, Howell non valeva Brooks ma soprattutto si è sbagliato nel puntare ancora sui “vecchietti” Michelori e Mordente i quali (soprattutto il secondo) stanno rendendo meno dell’anno scorso. Poi non ho capito il puntare su Sergio in uno spot di 4 così delicato dove già Scott non è un campionissimo, il ridare fiducia a Tommasini che mi pare non esploda nemmeno quest’anno (pur essendo molto migliorato). E su tutto questo una domanda: ma se c’erano i soldi per inserire Antonutti, Ivanov, Capin, Avramov e Tessitori, non era meglio investire qualcosina in più fin dall’inizio? La società dice che sono state operazioni a costo zero date le cessioni, ma non sono convinto. Comunque c’è stata anche tanta sfortuna, dall’infortunio a Vitali, a contrattempi vari alla prima vittoria che è mancata per un soffio in un paio di occasioni e che avrebbe, ne sono certo, sbloccato tutto. Certo è che si poteva allestire qualcosa di meglio, e qui lo staff (Atripaldi in testa) ha sbagliato valutazioni. La girandola di allenatori, poi, non aiuta. E se volevano Esposito lo avrebbero dovuto, coraggiosamente, prendere dall’inizio come head coach, non promuoverlo adesso spingendolo sull’ultima spiaggia. Credo sia (e ci mancherebbe) una presenza “ingombrante”, che non so quanto abbia aiutato.
Se ci si pensa, tutto questo è molto poetico. Affondare nonostante gli sforzi, nonostante il valore. Una specie di nemesi al contrario, di crudeltà gratuita. Speriamo di no.
Consiglia ai lettori una poesia che ti piace.
Consiglio una poesia di Giorgio Orelli, un grandissimo poeta svizzero di lingua italiana (cioè ticinese), probabilmente poco conosciuto in Italia. Questa la dedicò a Lino (e la moglie si chiamava Lina), un negoziante da cui lui si riforniva di materiale di ricambio per la propria macchina per scrivere.
In memoria
Tornavo per farmi cambiare
il nastro ormai privo d’inchiostro
della mia vecchia Olivetti, e allungando,
come faccio, passando in bicicletta
davanti al tuo negozio, l’occhio
di là dai vetri, ho visto
che non c’era nessuno (forse
Lina è di sopra con Dora)
e ho visto CHIUSO PER LUTTO (forse
è morto Lino): da un po’
non ti vedevo, non mi contavi storielle.
Volevo dirti che mi sono accorto
solo adesso della totale scomparsa,
a sinistra, di E, di O a destra.
Il tasto è nero ma sempre lucente,
se batto (eternamente con due dita) continuo
a vederle, bianchissime, intatte
o quasi, come, là in basso, la X.
Consiglia ai lettori una poesia di Raffaele Sabatino.
Consiglio l’ultima, che non fa parte di Malerbe e che spero di inserire in un prossimo libro.
L’eternità dei denti
Parrebbe che la parte più durevole
di noi non sia l’anima, piuttosto i denti;
non il cuore rimane, o le idee,
non lo spirito è eterno, o dio, o l’amore;
lo sono invece i nostri denti.
I Neandertaler? Riconosciuti
dai denti. Dinosauri, mammut,
tigri preistoriche? Catalogate
grazie a molari zanne e denti
a sciabola.
Serve pure agli sceneggiatori
di telefilm gialli la dentina
per identificare un tale ucciso.
E serve pure al poeta, il quale crede
che di noi non rimanga che sorriso.
Mi piace il cinema, poi mi piace correre. Mi piace viaggiare. Mi piace disegnare (ma lo faccio solo occasionalmente) e fotografare. Mi piacerebbe suonare, ma non ho mai imparato e forse lo farò. Mi piace ascoltare le storie degli altri (in un’altra vita forse farò lo psicologo). Mi piace osservare la crescita del mio bambino, la formazione delle sue idee, delle sue paure, la sua visione del mondo. Mi piacerebbe anche parlare molto e “scambiare” idee con altri esseri umani, cosa però per me al momento obbiettivamente abbastanza limitata. Quindi lo faccio indirettamente, scrivendo.
Sei un tifoso della JuveCaserta: cosa pensi del campionato?
Mentre sto scrivendo siamo alla tredicesima sconfitta consecutiva dall’inizio del campionato. Una cosa più unica che rara e che mi colpisce particolarmente, non solo da tifoso, ma perché mi pare che i risultati siano inversamente proporzionali agli sforzi della società (rinnovata attenzione al settore giovanile, restauro di vari luoghi cittadini di pallacanestro, collaborazione con la struttura dei salesiani e tante altre iniziative). Credo siano stati fatti degli errori di costruzione del roster. Gaines non valeva Roberts ma si voleva una guardia tiratrice, Howell non valeva Brooks ma soprattutto si è sbagliato nel puntare ancora sui “vecchietti” Michelori e Mordente i quali (soprattutto il secondo) stanno rendendo meno dell’anno scorso. Poi non ho capito il puntare su Sergio in uno spot di 4 così delicato dove già Scott non è un campionissimo, il ridare fiducia a Tommasini che mi pare non esploda nemmeno quest’anno (pur essendo molto migliorato). E su tutto questo una domanda: ma se c’erano i soldi per inserire Antonutti, Ivanov, Capin, Avramov e Tessitori, non era meglio investire qualcosina in più fin dall’inizio? La società dice che sono state operazioni a costo zero date le cessioni, ma non sono convinto. Comunque c’è stata anche tanta sfortuna, dall’infortunio a Vitali, a contrattempi vari alla prima vittoria che è mancata per un soffio in un paio di occasioni e che avrebbe, ne sono certo, sbloccato tutto. Certo è che si poteva allestire qualcosa di meglio, e qui lo staff (Atripaldi in testa) ha sbagliato valutazioni. La girandola di allenatori, poi, non aiuta. E se volevano Esposito lo avrebbero dovuto, coraggiosamente, prendere dall’inizio come head coach, non promuoverlo adesso spingendolo sull’ultima spiaggia. Credo sia (e ci mancherebbe) una presenza “ingombrante”, che non so quanto abbia aiutato.
Se ci si pensa, tutto questo è molto poetico. Affondare nonostante gli sforzi, nonostante il valore. Una specie di nemesi al contrario, di crudeltà gratuita. Speriamo di no.
Consiglia ai lettori una poesia che ti piace.
Consiglio una poesia di Giorgio Orelli, un grandissimo poeta svizzero di lingua italiana (cioè ticinese), probabilmente poco conosciuto in Italia. Questa la dedicò a Lino (e la moglie si chiamava Lina), un negoziante da cui lui si riforniva di materiale di ricambio per la propria macchina per scrivere.
In memoria
Tornavo per farmi cambiare
il nastro ormai privo d’inchiostro
della mia vecchia Olivetti, e allungando,
come faccio, passando in bicicletta
davanti al tuo negozio, l’occhio
di là dai vetri, ho visto
che non c’era nessuno (forse
Lina è di sopra con Dora)
e ho visto CHIUSO PER LUTTO (forse
è morto Lino): da un po’
non ti vedevo, non mi contavi storielle.
Volevo dirti che mi sono accorto
solo adesso della totale scomparsa,
a sinistra, di E, di O a destra.
Il tasto è nero ma sempre lucente,
se batto (eternamente con due dita) continuo
a vederle, bianchissime, intatte
o quasi, come, là in basso, la X.
Consiglia ai lettori una poesia di Raffaele Sabatino.
Consiglio l’ultima, che non fa parte di Malerbe e che spero di inserire in un prossimo libro.
L’eternità dei denti
Parrebbe che la parte più durevole
di noi non sia l’anima, piuttosto i denti;
non il cuore rimane, o le idee,
non lo spirito è eterno, o dio, o l’amore;
lo sono invece i nostri denti.
I Neandertaler? Riconosciuti
dai denti. Dinosauri, mammut,
tigri preistoriche? Catalogate
grazie a molari zanne e denti
a sciabola.
Serve pure agli sceneggiatori
di telefilm gialli la dentina
per identificare un tale ucciso.
E serve pure al poeta, il quale crede
che di noi non rimanga che sorriso.